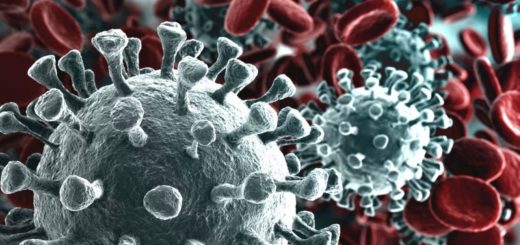La peste di Atene (430 a.C.) da Tucidide, Le Storie, libro II
a cura di Adriano Simoncini
Di Tucidide (circa 460 – 400 a.C) ho detto nel numero precedente. Dalle sue Storie trascrivo la descrizione dell’epidemia di peste che sconvolse Atene mentre combatteva contro Sparta e i suoi alleati per il predominio sul mondo ellenico. Pagine meritatamente famose, da confrontarsi con quelle esemplari di altri autori – Boccaccio, Manzoni, Camus… – che descrissero epidemie altrettanto devastanti. La traduzione è ancora quella di Guido Donini per l’UTET.
Era l’estate del 430 a.C. e iniziava il secondo anno della guerra… quando la peste cominciò a manifestarsi per la prima volta tra gli Ateniesi: si diceva che anche prima fosse scoppiata… in altri luoghi, tuttavia non si ricordava che ci fosse stata da nessuna parte una peste talmente estesa né una tale strage di uomini. Né i medici erano di aiuto a causa della loro ignoranza, poiché curavano la malattia per la prima volta… né serviva nessun’altra arte umana. Tutte le suppliche che facevano nei templi o l’uso che facevano di oracoli e cose simili, tutto ciò era inutile; e alla fine essi se ne astennero, sgominati dal male… Io stesso ho avuto la malattia e io stesso ho visto altri che ne soffrivano…
Se qualcuno aveva già qualche indisposizione, in tutti i casi essa finiva in questa. Gli altri invece, senza nessuna causa apparente, mentre erano sani improvvisamente venivano presi da violente vampate di calore alla testa e da arrossamenti e infiammazioni agli occhi, e tra le parti interne la faringe e la lingua erano subito sanguinolente ed emettevano un alito insolito e fetido. Poi, dopo questi sintomi, sopravveniva lo starnuto e la raucedine, e dopo non molto tempo il male scendeva nel petto, ed era accompagnato da una forte tosse. E quando si fissava nello stomaco, lo sconvolgeva, e ne risultavano vomiti di bile … accompagnati da una grande sofferenza… Esternamente il corpo non era troppo caldo a toccarlo, né era pallido, ma rossastro, livido e con eruzioni di piccole pustole e di ulcere. L’interno invece bruciava in modo tale che i malati non sopportavano di esser coperti da vesti o tele di lino leggerissime, né sopportavano altro che l’esser nudi… molti dei malati trascurati… si precipitavano nelle cisterne in preda a una sete inestinguibile…La difficoltà di riposare e l’insonnia li affliggevano continuamente… La maggior parte dei malati moriva il nono o il settimo giorno a causa del calore interno… oppure, se si salvavano, la malattia scendeva ancora nell’intestino, si produceva in esso una ulcerazione violenta, e insieme sopraggiungeva un attacco di diarrea completamente liquida, e a causa della debolezza che essa provocava i più in seguito decedevano… Gli uccelli e i quadrupedi che si cibano di carne umana, benché molte persone giacessero insepolte, non si avvicinavano a loro, oppure, se se ne cibavano, morivano…
Nessun corpo si dimostrò sufficientemente forte per resistere al male, fosse robusto o debole, ma esso li portava via tutti, anche quelli che erano curati con ogni genere di dieta. Ma la cosa più terribile di tutte nella malattia era lo scoraggiamento quando uno si accorgeva di essere ammalato… e il fatto che per aver preso la malattia uno dall’altro mentre si curavano, morivano come le pecore: questo provocava il maggior numero di morti. Da una parte, se non erano disposti a far visita gli uni agli altri, per paura, morivano abbandonati, e molte case furono spopolate per mancanza di qualcuno che potesse venire a curare i malati che vi abitavano; d’altra parte, quelli che si recavano dai malati perivano, soprattutto quelli che cercavano di praticare la bontà. Grazie al loro senso dell’onore non si risparmiavano nell’entrare nelle case degli amici, dato che alla fine addirittura i familiari interrompevano per la stanchezza anche i lamenti per quelli che morivano, vinti come erano dall’immensità del male. Tuttavia, più degli altri coloro che erano scampati avevano compassione per chi stava morendo o era malato, perché avevano già avuto l’esperienza della malattia e perché loro ormai erano in uno stato d’animo tranquillo. Il morbo infatti non coglieva due volte la stessa persona in modo da ucciderla. E gli altri si congratulavano con loro; ed essi stessi, nella gran gioia del momento, avevano un po’ di vana speranza che anche in futuro nessuna malattia li avrebbe mai potuti uccidere.
Oltre al male già esistente li opprimeva anche l’afflusso di gente dalla campagna nella città: ciò affliggeva maggiormente coloro che erano arrivati da fuori. Poiché non c’erano case disponibili, ma essi abitavano in capanne soffocanti per la stagione dell’anno, la strage avveniva con grande confusione: corpi di moribondi giacevano uno sopra l’altro, e persone mezze morte si muovevano barcollando nelle strade e intorno a tutte le fontane per il desiderio d’acqua. I templi nei quali si erano sistemati erano pieni di cadaveri, dato che la gente vi moriva: infatti, poiché il male imperversava, gli uomini non sapendo che cosa sarebbe stato di loro si volgevano al disprezzo così delle cose sacre come delle profane. Tutte le usanze che avevano seguito in precedenza per le sepolture furono sconvolte; e seppellivano i corpi ciascuno come poteva. E molti ricorrevano a modi vergognosi di sepoltura, per mancanza delle attrezzature necessarie, poiché avevano già avuto parecchi morti in famiglia: mettevano il cadavere del proprio morto su una pira altrui, anticipando quelli che l’avevano costruita, e poi l’accendevano. Altri gettavano il morto che stavano portando sopra un altro che bruciava, e poi se ne andavano.
Anche per altri aspetti la malattia segnò nella città l’inizio di un periodo in cui il disprezzo delle leggi era più diffuso. Infatti più facilmente si osava fare cose che prima di allora si facevano di nascosto, senza mostrare che si seguiva il proprio piacere: vedevano che era rapido il mutamento di sorte dei ricchi, che morivano improvvisamente, e di coloro che prima non possedevano nulla, ma che subito divenivano padroni dei beni dei morti. Così pensavano di dover godere rapidamente di ciò che avevano e di servirsene a lor piacere, considerando le loro vite e le loro ricchezze ugualmente effimere. E nessuno era pronto a sopportare fatiche per ciò che era considerato onesto, perché pensava che non vi era certezza di non perire prima: ciò che al momento presente era piacevole, e che in qualunque modo era vantaggioso ai fini del piacere, questo divenne onesto e utile. Nessun timore degli dei e nessuna legge degli uomini li tratteneva: da una parte giudicavano che fosse la stessa cosa essere religiosi o meno, dal momento che vedevano tutti morire egualmente, e dall’altra nessuno si aspettava di vivere fino a quando ci sarebbe stato un giudizio sulle sue colpe e di scontarne la pena: pensavano che molto maggiore fosse l’incombente punizione già decretata contro di loro, e che prima che si abbattesse fosse ragionevole godersi un po’ la vita.
Tale era la sciagura in cui gli Ateniesi erano piombati e da cui erano afflitti; e mentre all’interno della città la popolazione moriva, fuori la terra veniva devastata dalla guerra.