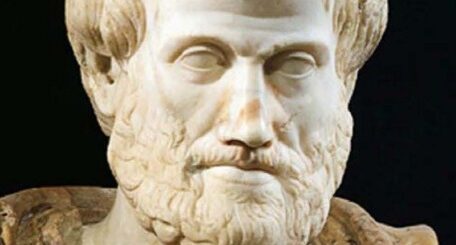Diario del Festivafilosofia 2007 sul “Sapere” – parte terza
di Giorgio Morgione
Appunti liberi di Lezioni Magistrali
Parte Terza
Umberto Galimberti: Dal sapere simbolico al sapere tecnologico
Carpi, piazza dei Martiri, Sabato 15 Settembre 2007
Il giuoco dei poli entro il quale si consuma l’esistenza dell’essere umano, l’esistenza dell’essere pensante, è quello tra l’universo simbolico e il sapere tecnologico, oppure, in altri termini, tra l’enigma e la razionalità strumentale. Alla base di tutto questo è la scissione tra anima e corpo, scissione che ha inaugurato la scienza moderna e che oggi, nel trionfo della tecnica, è giunta al suo parossismo.
Ma incominciamo da una domanda che si pone a monte: il sapere è davvero una ricerca della verità? La risposta, afferma Galimberti, è no. Prendendo spunto dalla dottrina della genealogia nicciana, secondo la quale non dobbiamo domandarci l’essere dell’oggetto, quanto da dove esso venga, Galimberti considera il sapere piuttosto come un’istituzione umana preposta alla previsione dell’imprevedibile: esso è stato fondato unicamente per contenere l’angoscia degli uomini, la paura dell’imprevisto. L’uomo vive se prevede. Sapere è dunque tentativo di superamento della paura. I bambini ad esempio, che ignorano i nessi più semplici delle cose, sono continuamente in allarme.
Domandiamoci a questo punto cosa sia il simbolo, e domandiamoci anche quale sia il significato del pensiero simbolico. Il simbolo (syn, insieme + ballo, getto, pongo, = mettere insieme) è il risultato del processo attraverso il quale l’oggetto riceve un portato della psicologia del soggetto. Ad un primo esame un tale processo non può far altro che accrescere la distanza cognitiva tra il soggetto e l’oggetto. Il primo ad aver avuto questo sospetto è stato Platone, il quale ci dice che se vogliamo istituire un linguaggio universale, dobbiamo anzitutto scardinare il simbolo. Per cercare l’oggetto così come è e non sottoforma di un dio, di un’emozione o altro, è necessario liberarsi dai gangli del pensiero simbolico, ovvero imparare a conoscere l’oggetto secondo il principio di non contraddizione, il principio di identità, ed espungendo il dato psicologico e corporale che insidia continuamente il processo di costruzione del linguaggio. Ecco perché Platone afferma che i poeti rappresentano un male per la comunità. Il corpo non informa bene, il corpo inganna. Sarebbe necessario istituire un sapere fatto soltanto di numeri ed idee, scacciando il corpo e le emozioni. Tale vuole essere il linguaggio filosofico, fatto di razionalità ed astrazione, tale è il linguaggio col quale io posso dire che questa sedia è quel che è, in ogni luogo e in ogni tempo. Questo è l’Occidente, la cui storia può riassumersi nella lunga istituzione di un sapere fondato sulla scissione dell’oggetto dal soggetto, attraverso il numero, le idee, la negazione, dati con i quali l’Occidente costruisce la struttura del discorso.
Il primo importante traguardo di questa storia è il linguaggio scientifico. L’uomo è qui un giudice che ha come imputato la natura. L’uomo decide cosa la natura sia e come vada trattata: Heidegger coglie pienamente il senso di questo dato, quando dice che il mondo si organizza mediante l’esigenza umana, quindi un fiume è una risorsa di energia elettrica, il suolo è sottosuolo, il lago una riserva idrica ecc.
Il secondo traguardo della storia dell’Occidente è il linguaggio tecnologico. Qui occorre domandarsi cosa sia la tecnica. Essa è una realtà complessa, che possiamo definire come l’insieme degli strumenti, come la forma più alta di razionalità che l’uomo abbia mai raggiunto, nella quale non esiste spreco, non esiste sovrabbondanza, c’è perfetta armonia tra mezzo e scopo, essenzializzazione radicale della vita, ancor più di quanto accade nell’economia, perché il modello di riferimento della tecnica è la macchina. L’uomo di fronte alla macchina è un essere profondamente diverso, ed è così che egli, per vivere in armonia con la tecnica, deve adeguarsi ad essa, fino a divenire non più l’heideggeriano “pastore dell’essere”, bensì, come direbbe Günter Anders, “il pastore delle macchine”. L’uomo cerca la propria identità nel riconoscimento in un proprio apparato di appartenenza, anzi, si può arrivare a dire che la sua identità è oramai interamente delegata all’apparato. La tecnica essenzializza la vita e la natura, si contrappone a tutto ciò che è incomprensibilmente sovrabbondante, generoso, come è sovrabbondante e generoso il linguaggio di due innamorati. La vita, dunque, è incomparabile con la tecnica e viceversa.
Qual è la conseguenza di tutto questo? Il dato più rilevante è che noi perdiamo il contatto con noi stessi: l’apparato ci conduce allo smarrimento, perché ha espulso il simbolico, lo psichico, l’emotivo, ha espulso il mondo della vita. La tecnica ci allontana dalla conoscenza di sé, e poiché la natura non istintuale dell’uomo lo obbliga a prendersi cura di sé, la tecnica ci allontana anche dal prenderci cura di noi stessi. L’uomo è in grado di prendesi cura di sé in molti modi diversi. Quella cristiana, per esempio, è stata ed è ancora una cura largamente adottata. Essa ha trovato il modo di reperire il senso della vita per l’uomo nell’idea di un’esistenza ultraterrena. Così facendo, il Cristianesimo ha conferito un senso al tempo iscrivendolo in un disegno escatologico nella cui fine si realizza la salvezza annunciata all’inizio. Dentro il Cristianesimo c’è una domanda di senso, ovvero un modo con cui l’uomo ha voluto prendersi cura di se stesso. Ma per ogni animo, la cura del Cristianesimo si traduce in una pratica di buona condotta, la quale a sua volta si traduce in una morale della repressione, finché ciò che doveva essere una cura si tramuta in afflizione. Oggi, continua Galimberti, non è più la repressione che ci affligge, ma la mancanza di senso: la tecnica ci priva di senso e ci precipita nell’angoscia. Ci ostiniamo a cercare un senso alla nostra vita quando la nostra vita ha il solo senso di vivere, per finire nel turbine dell’apparato che ci allontana dalla comprensione di noi stessi.
La vita è una dimensione prerazionale, esattamente come il simbolo, così se non entriamo nella simbolica dell’altro non potremo mai intenderci appieno col prossimo. La ragione dunque, la razionalità, non è tutto, ma un insieme di regole. La dimensione della ragione galleggia nell’oceano del simbolico. I simboli sono potenti e i conflitti del nostro tempo stanno a dimostrarlo: con le ragioni ci si mette d’accordo, con i simboli no. La riappropriazione del senso e della cura di sé dipende così dalla possibilità di trovare un canale di comprensione tra diversi sul piano del simbolico. Il dialogo, inteso come un conflitto simulato tra due ragioni contrapposte (dia–logos, contrapposizione di logoi) è esattamente ciò che costituisce questo canale. Il dialogo come recupero di senso e cura di sé è possibile nella misura in cui ci riconosciamo come portatori di quella cifra prerazionale che è il simbolico, attraverso quel che James Hillman ha definito come un codice archetipico col quale ci individuiamo e candeziamo la nostra vita.
Umberto Galimberti (Monza, 1942). Filosofo italiano. Allievo di E. Severino, è attualmente ordinario di Filosofia della Storia all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Al centro della sua ricerca è il rapporto tra l’uomo e la tecnica nel mondo contemporaneo. Tra le sue opere più importanti: Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente (1975), Psichiatria e Fenomenologia (1979), Il corpo (1983), La terra senza il male. Jung dall’inconscio al simbolo (1984), Gli equivoci dell’anima (1987) e Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica (1999).