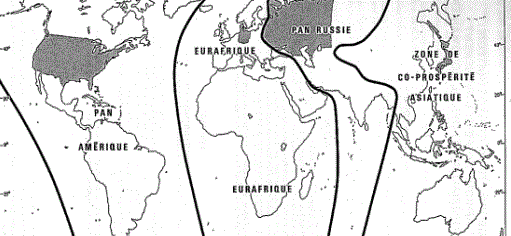Seconda questione di geopolitica: il “cuore della terra” al fronte sud
di Uber Serra
Nella prima puntata di questa inchiesta sullo stato attuale della narrazione geopolitica autentica (quella di H. Mackinder, per intenderci) s’è detto che per essa c’è un luogo privilegiato del pianeta il cui governo consentirebbe il dominio del mondo: è questo il “cuore della terra” (o Heartland) che coincide con la Russia nella estensione delle steppe dal Dniepr alla Kamciakta. Però la Russia è stretta dal Mar Glaciale Artico a nord e dalla fascia dei deserti asiatici a sud, sicché per esercitare il pieno controllo sul pianeta dovrebbe spingere la propria supremazia su una di quelle “terre di confine” (poi dette Rimlands dal geopolitico americano Nicholas Spykman) che la circondano ad ovest (Europa e Balcani), a sud (Medio Oriente e Persia) e a est (Cina e Corea) e che si affacciano, per l’appunto, sui mari caldi. Proprio per evitare tanta jattura Mackinder aveva affidato, al suo tempo, alle due isole dirimpettaie al continente euroasiatico, la Gran Bretagna e il Giappone, il compito strategico di “salvare” il mondo dalle mire planetarie di Mosca, un compito però che dopo la seconda guerra mondiale, avendo tradito il Giappone il suo “dovere” geopolitico ed essendosi esaurita la Gran Bretagna a sua difesa, è stato assunto su tutti i fronti dai più robusti e onnipresenti Stati Uniti d’America. Ed è questo il “destino” americano che perdura tuttora sebbene l’URSS sia scomparsa, e questo perché la Russia è cattiva non perché zarista, sovietica o quant’altro, ma perché geopoliticamente resta comunque il “cuore della terra”.
E’ per questo che sono stati clamorosamente smentiti tutti coloro che avevano immaginato che, caduta la “cortina di ferro”, fosse possibile cancellare l’alleanza a guida americana della Nato, quando invece proprio la Nato è servita a dar sostegno alle “rivoluzioni colorate” nei paesi ex-satelliti sovietici, dal Baltico ai Balcani, allo scopo d’incorporarli nell’arena del c.d. “mondo libero”. Ed il gioco è andato bene finché, allungando le mani sull’Ucraina, ci si è scontrati col fermo stop di Putin, che dapprima ha imposto la secessione della Crimea (dove peraltro risiede da tempo la più grande base navale russa sul Mar Nero) e poi ha dato (e continua a dare) il proprio sostegno alla sollevazione armata del Donbass senza che le sanzioni economiche europee valgano a farlo desistere. Così, al momento, sul fronte ovest del “cuore della terra” siamo allo stallo geopolitico, con le parti contendenti che si fanno vicendevolmente il “viso delle armi”, ma guardandosi bene di compiere quel passo in più che potrebbe portare ad un confronto militare diretto, troppo pericoloso perché entrambe dotate di armamento nucleare.
Ben diversa è stata invece la dinamica geopolitica al fronte sud, dove gli Stati Uniti e la Russia si sono trovati coinvolti in un Medio Oriente lacerato dall’acutizzarsi del secolare contrasto religioso islamico tra sunniti e sciiti (analogo, per capirci, alla spaccatura del cristianesimo tra cattolici e ortodossi e con gli sciiti a giocare la parte dei cattolici). A seguito della rivoluzione iraniana del 1979 l’apostasia sciita è tornata prepotentemente alla ribalta, guadagnando per altro nuova lena nel 2003 con la caduta di Saddam Hussein (sunnita) in un Iraq a maggioranza sciita e poi nel 2006 in Libano con la vittoria elettorale dell’altrettanto sciita “partito di Dio” (Hezbollah). Al momento, gli sciiti governano in Iran, Iraq e Libano, ma pure in Siria nella variante alawita (sebbene la maggioranza della popolazione sia sunnita), dando così consistenza ad una continuità territoriale che da Teheran, via Bagdad e Damasco, arriva fino a Beirut, a rappresentare un possibile Sciistan che allarma gli stati arabi del Golfo Persico che sono invece tutti sunniti (una agguerrita componente sciita è presente soltanto nello Yemen).
In questo groviglio politico-religioso come si sono mossi gli Stati Uniti? Ad interpretare maliziosamente, si può anche pensare che il celebre discorso di Obama al Cairo nel 2009 abbia rappresentato una sorta di invito ad una riscossa sunnita che, dopo aver detronizzato in successione le decotte autocrazie islamiche affacciate sul Mediterraneo (dalla Tunisia alla Libia e all’Egitto, ma quelle sul Golfo Persico ne sarebbero rimaste esenti), avrebbe colto il suo maggior successo cacciando Assad dalla Siria ad interrompere quel “corridoio sciita” che collega Teheran al Mediterraneo. Ed invero è quanto è successo con le tanto decantate “primavere arabe” del 2011, ma i risultati sono stati assai deludenti se, a seguito dell’intervento militare d’appoggio primariamente voluto dal governo francese, la Libia è precipitata in una guerra per “bande tribali” che minacciano la secessione della Cirenaica dalla Tripolitania, mentre in Egitto la vittoria elettorale dei Fratelli Musulmani ha costretto (come in Algeria nel 1992) ad eliminare da subito il governo appena eletto con un golpe militare (fortunatamente senza quel seguito di guerra civile come è avvenuto invece in Algeria).
Quando poi si è arrivati al “nodo siriano”, che era quello più importante, è stato un disastro perché nella ribellione sunnita contro il regime di Assad si sono infilati i fautori della “guerra santa” (jihad) contro tutti gli infedeli presenti in Siria ed Iraq, e quindi non soltanto contro i “nemici naturali” sciiti (a dimostrazione c’è stato a Teheran uno spettacolare doppio attentato al Parlamento e al mausoleo di Khomeini nel 2017), ma pure contro i “crociati” americani ed europei e contro i curdi, che da tempo infastidiscono la Turchia con la loro intenzione di darsi un Curdistan a cavallo del suo confine territoriale. E così, approfittando della ribellione sunnita anti-Assad, i fondamentalisti dello “Stato Islamico di Siria e Iraq” (ISIS, se letto all’incontrario) nel 2014 hanno proclamato a Raqqa il proprio Califfato, embrione geografico di quel Sunnistan che si sarebbe incuneato a separare il Libano ed una striscia costiera di Siria alawita dall’odiatissimo Iran. Ma la delinquente irruzione dell’ISIS ha imposto agli Stati Uniti e all’Europa, a difesa della minoranza cristiana dai fanatici islamisti, a non sostenere a sufficienza l’Esercito di Liberazione anti-Assad e ad appoggiare i ribelli curdi sia in Siria che in Iraq con grande dispetto del governo di Ankara.
Nella confusione generale il governo di Damasco ha trovato però altri alleati per reprimere la ribellione, innanzitutto l’Iran che ha inviato anche dei propri combattenti in sostegno, e poi la Russia perché a Tarsus, sulla costa siriana, è presente l’unica sua base navale affacciata nel Mediterraneo che non intende affatto perdere ad opera di ribelli filo-occidentali. E così, grazie alla forte copertura aerea russa che ha bombardato a più non posso, Assad ha riconquistato Homs nel 2014 e Aleppo nel 2016. E se nel 2013 il presidente americano Obama aveva pur avvertito Damasco di non superare la “linea rossa” dell’impiego di armi chimiche contro i ribelli, quando sono state utilizzate (o almeno così si è denunciato) Washington non ha reagito anche per la preoccupazione internazionale di una possibile reazione di forza di Putin. A testarne la determinazione ci ha provato solo la Turchia che sul finire del 2015, accusando la violazione del proprio spazio aereo, ha abbattuto un bombardiere russo, ma con l’effetto di vedersi impiantare da Mosca una base missilistica a Latakia in funzione proprio anti-turca.
Nel 2017 col nuovo presidente Trump è sembrato che cambiasse lo “stile” diplomatico della Casa Bianca e quando è ritornata l’accusa ad Assad di aver usato ancora armi chimiche, dalle navi americane alla fonda nel Mediterraneo sono partiti 59 missili di rappresaglia contro una base siriana (ma Putin sarebbe stato allertato in anticipo, così da non lamentare perdite di propri militari). Come che sia, Putin non ha riconosciuto l’accusa d’impiego di armi chimiche e per ritorsione ha mandato a bombardare sia i ribelli anti-Assad che i terroristi dell’ISIS. Ma non è che nei cieli siriani ci sono ormai troppi aerei in volo? E così si devono aprire contatti diplomatico-militari tra Mosca e Washington onde evitare che i rispettivi top gun finiscano per spararsi addosso.
Sul terreno, invece, è la copertura aerea americana a nord a favorire i ribelli curdi, che nel 2017 conquistano Raqqa (in Siria) e Mosul (in Iraq) ponendo così fine al Califfato dell’ISIS. E mentre i jihadisti superstiti si trasferiscono negli attacchi dei “lupi solitari” in Europa o nelle guerriglie islamiche nel Maghreb ad infastidire (per il momento soltanto infastidire) gli interessi coloniali francesi, i curdi vittoriosi già pensano di poter dar vita nel territorio liberato lungo la frontiera siro-irachena ad il loro agognato Curdistan. Il quale, comunque, è osteggiato dalla Turchia dove, nel 2016, un maldestro golpe militare ha pur provato, fallendo, a deporre il “sultano” Erdogan. A dar retta a fake-news, Erdogan sarebbe stato informato in anticipo del complotto da Putin e sarebbe sfuggito ai congiurati in aereo trovando a Teheran quella ospitalità provvisoria rifiutatagli invece dalla Germania. Sopravvissuto alla crisi di regime, ha così potuto provvedere a far piazza pulita dei suoi oppositori con una epurazione di massa che è ancora in corso, ma ha pure rivisto il proprio collocamento geopolitico avvicinandosi ai suoi “salvatori” Russia ed Iran. E poi, di nuovo saldo in sella, con l’occupazione militare di Afrin in Siria nel 2018 ha cominciato a cancellare quel Curdistan che vede come il fumo negli occhi.
E l’America in tutto questo che ha fatto? E’ restata a guardare? C’è il fatto nuovo che per l’amministrazione Trump Putin non è più il “nemico principale”: trovatasi bloccata in Europa dal “dispositivo Nato” (la secessione della Crimea è considerata un atto difensivo più che offensivo), la Russia si sta invischiando troppo, nel ginepraio mediorientale, in una incerta alleanza con siriani, iraniani e turchi da cui potrebbe anche uscire con le ossa rotte. A difendere gli interessi americani nell’area possono quindi bastare, col grande vantaggio di non richiedere truppe sul terreno, il “baluardo israeliano” (intoccabile perché dotato di armamento atomico e a cui Trump regala lo spostamento dell’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme) e la nuova Arabia saudita del “golpista dinastico” Mohammed bin Salman che, dopo aver detronizzato la parentela, nel 2017 inalbera la bandiera ufficiale della “crociata” (se si può dire) anti-sciita. E subito intima al Qatar (che sarebbe un “cesso di paese”, per dirla con Trump, ma prima di essersi trovato padrone, ma in condominio con il prospiciente Iran, di un gigantesco giacimento di gas naturale nel Golfo Persico) di cessare ogni sostegno, anche tramite l’emittente televisiva Al Jazeera, ai “fondamentalisti” islamici comunque declinati, ma soprattutto di interrompere ogni rapporto con Teheran, altrimenti sarebbe stato l’embargo – e l’unica frontiera terrestre del Qatar è con l’Arabia saudita. E poi nel 2018 decide di chiudere la partita con la ribellione sciita nello Yemen mediante assedi e bombardamenti indiscriminati che vanno avanti nella più sfacciata indifferenza della c.d. “coscienza del mondo”.
Nella prospettiva geopolitica “trumpista” ciò che più preoccupa adesso non è tanto la Russia, vecchio nemico da guerra fredda, ma la Cina che è in via di progressiva affermazione non soltanto commerciale, ma pure finanziaria avendo l’obiettivo ultimo di scalzare il dollaro dalla funzione di “moneta mondiale” per sostituirlo con lo yuan (proprio come aveva fatto il dollaro, nella prima metà del Novecento, a spese della sterlina). Ora c’è pericolo che un aiuto decisivo in questa deriva possa venire proprio dagli Stati Uniti se, per intransigenza nei confronti di Mosca, costringessero il “cuore della terra” a ricercare, giusto il teorema geopolitico di Mackinder, quello sbocco ai mari caldi, impeditole ad ovest e a sud, in direzione d’oriente, dalla parte della Cina dunque, lungo quella “via ferroviaria della seta” che, attraversando la Siberia, già prova a collegare Mosca a Pechino. E se mai Cina e Russia si compattassero, non ne potrebbe uscire una inedita entità geopolitica come Russasia, con esportazione di materie prime ed energia da una parte ed esportazione di manufatti e capitali dall’altra, ben difficilmente ostacolabile?
E’ una preoccupazione americana di cui si parla poco, ma di cui c’è almeno una traccia evidente nel libro scandalistico Fuoco e furia di Michael Wolff (Rizzoli, 2018) che narra la conquista e poi l’occupazione della Casa Bianca da parte di Donald Trump grazie soprattutto al sostegno della sua “eminenza grigia” Steve Bannon. Ed è proprio Bannon che nel Prologo a domanda risponde: “ ‘Tanto per cominciare sposteremo l’ambasciata americana a Gerusalemme. Netanyahu è d’accordo… La linea di condotta è già decisa’. ‘E Donald lo sa?’. Bannon gli rivolse un sorriso quasi complice, e proseguì: ‘Che la Giordania si prenda pure la Cisgiordania e l’Egitto la striscia di Gaza. Che se ne occupino loro o colino a picco nel tentativo. I sauditi sono sull’orlo di una guerra, gli egiziani anche, e hanno tutti un sacro terrore dell’Iran… Yemen, Sinai, Libia: la situazione è pessima. Per questo la Russia è la chiave. E in fondo che cos’ha la Russia che non va? Certo, sono i cattivi, ma il mondo è pieno di cattivi’. Aveva parlato con il fervore di un uomo che sta ridisegnando la carta geopolitica mondiale… Il vero nemico, riprese Bannon, era la Cina. La Cina era il fronte principale di una nuova Guerra fredda. E negli anni di Obama nessuno se n’era accorto: credevano di sapere, invece non avevano capito niente. Colpa dell’incompetenza dell’intelligence americana… ‘E qual è la posizione di Donald in proposito?’, lasciando chiaramente intendere che considerava Bannon molto più avanti del suo benefattore. ‘E’ d’accordo con me al cento per cento.’ ‘E’ sul pezzo?’ ‘Quanto basta’ ”.