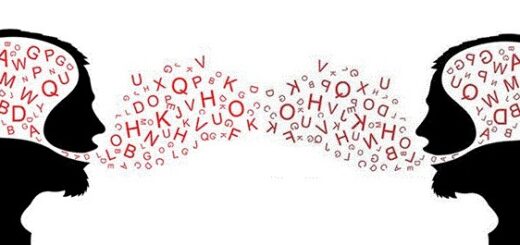216 a.C., a Canne e a Roma, dopo la strage – da Tito Livio, Ab urbe condita libri
antologia storica a cura di Adriano Simoncini
Tito Livio, lo storico di Roma celebrato per la coinvolgente vastità della sua opera, nacque a Patavium, Padova, nel 59 a.C. e morì, incerto il luogo, nel 17 d.C. Di famiglia facoltosa, l’educazione ricevuta gli consentì di apprendere correttamente il latino e il greco. Conclusi gli studi venne a Roma dove trascorse molta parte della sua vita, interamente dedita alla stesura della storia di una città che da umili origini era diventata, con il patrocinio degli Dei, la signora del mondo. A Roma ebbe infatti la possibilità di accedere ai documenti e ai testi indispensabili alla sua ricerca storiografica. Nonostante fosse in amicizia con Augusto, non ricoprì alcuna carica pubblica. Tuttavia, già in vita, godette di rinomanza e ammirazione che sono continuate nel tempo. L’opera di Livio – Ab urbe condita libri – comprendeva 142 libri: iniziava con l’arrivo di Enea in Italia e si concludeva – forse per la morte dell’autore – nel 9 a.C. con la descrizione dei funerali di Claudio Druso, fratello di Tiberio Nerone. Dei 142 libri originali soltanto 35 ci sono rimasti per esteso: le decadi prima, terza, quarta e la prima metà alquanto lacunosa della quinta; della parte rimanente rimangono frammenti non sempre di certa collocazione.
La traduzione dal latino è di Almerico Ribera per le edizioni Mondadori – I Classici Collezione 2007, Storia di Roma. Dal terzo volume trascrivo alcuni brani (libro XXII pp. 255-267, passim) che narrano gli avvenimenti immediatamente successivi alla sanguinosa sconfitta patita a Canne dai Romani a opera di Annibale nel 216 a.C.
Tutti circondavano il vincitore Annibale e si congratulavano con lui e lo esortavano a dare a se stesso e ai soldati stanchi, ora che quella sì gran guerra era compiuta, riposo per il resto della giornata e per la notte seguente. Maarbale invece, il comandante della cavalleria, pensava che non si dovesse indugiare: “Anzi,” disse “perché tu ben sappia quanto si sia ottenuto con questa giornata [o ti dico che] fra cinque giorni banchetterai vincitore sul Campidoglio. Seguimi; io ti precedo con la cavalleria affinché ti sappiano giunto prima di apprendere che ti sei messo in marcia”. Troppo bella cosa parve questa ad Annibale, ma troppo più grande che si potesse lì per lì deliberarla. Disse dunque che elogiava la buona volontà di Maarbale, ma che occorreva un po’ di tempo per ponderare siffatto consiglio. Al che Maarbale: “Eh sì, a nessuno danno tutto gli dei; tu sai vincere Annibale, ma non sai sfruttare la vittoria”. E ben si crede che l’indubbio di quel giorno fu la salvezza dell’Urbe e dell’impero.
L’indomani all’alba attesero raccogliere le spoglie e contemplare la strage, orrenda anche per un nemico, tanti migliaia di romani giacevano, fanti misti a cavalieri, come le aveva accomunati il caso o nel combattimento o nella fuga. Alcuni, riscossi dal dolore delle ferite inaspritesi per il freddo mattutino, si alzavano insanguinati di tra il carnaio e furono finiti dai nemici. Altri ne trovarono vivi coi femori o coi popliti recisi, che si denudavano la gola e la nuca e chiedevano che fosse loro tolto il sangue rimasto. Altri furono trovati con la testa ficcata in una buca, e si vedeva che se le erano scavate essi stessi, e che gettandosi e coprendosi di terra si eran tolta la vita. Particolarmente fu notato un Numida ancora vivo, tratto di sotto a un Romano che gli giaceva addosso, con le orecchie e col naso strappati, giacché quello non potendo più con le mani far l’uso dell’arma, di irato divenuto rabbioso, era spirato addentando il nemico.
Continuò fino a giorno inoltrato la raccolta delle spoglie; dopodiché Annibale mosse ad assaltare il campo minore e, innanzitutto, con un con una linea fortificata, li tagliò fuori dal fiume. Del resto la resa venne più presto ch’egli non sperasse, essendo tutti prostrati dalla fatica e anche dalle ferite. Fu pattuito che consegnassero armi e cavalli e che il riscatto avesse ad essere di trecento nummi quadrigati per ogni Romano, di duecento per ogni socio e di cento per gli attendenti, e che, pagato tal prezzo, potessero andarsene con una veste; poi nemici li fecero entrare nel proprio campo e furono tutti messi sotto custodia, i Romani divisi dai soci.
Mentre là si perdeva così il tempo, dal campo maggiore si erano rifugiati a Canosa circa quattromila uomini e duecento cavalieri, ai quali erano bastati l’animo e le forze, alcuni ordinati in schiera, altri gettatisi disordinatamente per i campi (il che non era meno sicuro); il campo fu poi consegnato al nemico, con le stesse condizioni fatte dall’altro, dai feriti e dai pavidi ivi rimasti.
Copiosissimo fu il bottino e, tranne i cavalli e gli uomini e tutto quello che v’era di argento (e ve n’era molto nelle falere dei cavalli, giacché usavano poca argenteria da tavola, particolarmente durante la milizia) tutto il resto fu dato a saccheggiare. Poi Annibale ordinò che si adunassero i cadaveri dei loro, per seppellirli. Si dice che fossero ottomila, tutti gagliardissimi guerrieri. E secondo alcuni scrittori fu cercato e sepolto anche il console romano (…)
A Roma non era stato neppure annunziato che erano rimaste queste reliquie di cittadini e di soci, ma avevano riferito che tutto l’esercito coi due consoli e con tutte le genti fosse stato tagliato a pezzi. Non c’era mai stato entro le mura romane, pur essendo incolume la città, tanto sbigottimento e sì grande tumulto Mi dichiaro perciò impari al compito, e non tenterò di raccontare quello che con le mie parole farei minore del vero. Dopo la perdita, nell’anno precedente, di un esercito e di un console, ora si annunciava non già una nuova ferita ma un disastro ben maggiore: due consoli e due eserciti consolari erano distrutti; non c’erano più né un campo romano né comandanti né soldati; Annibale aveva in suo potere la Puglia, il Sannio e ormai quasi tutta l’Italia. Certo nessun altro popolo avrebbe saputo non crollare sotto il peso di tanta rovina (…)
Allora giunse finalmente una lettera del console Caio Varrone [annunziante che]: il console Lucio Emilio e l’esercito erano periti; egli era in Canosa e raccoglieva, quasi da naufragio, le reliquie di sì immane disastro; i soldati dispersi e senza ordine erano circa diecimila; il Cartaginese ero fermo a Canne intento a mercanteggiare i riscatti dei prigionieri e le altre prede, non davvero con spirito di vincitore né secondo l’uso proprio un gran capitano. Si conobbero allora anche dalle famiglie le perdite dei rispettivi congiunti, e di tal lutto fu piena la città che forse fu sospesa l’annua festa di Cerere, ché né era lecito celebrarla da chi fosse in lutto, né si trovò in quella circostanza alcuna matrona che in lutto non fosse (…)
Oltre a tanti disastri, erano tutti sbigottiti sì da nuovi prodigi e sì dal fatto che in quell’anno due vestali, Opimia e Floronia, erano state scoperte colpevoli di fornicazione, e l’una stata seppellita viva secondo l’uso presso la porta Collina, l’altra si era da sé tolta la vita. Lucio Cantilio, scriba del pontefice, uno di quelli che ora sono chiamati pontefici minori, che aveva fornicato con Floronia, era stato pubblicamente flagellato con le verghe dal pontefice massimo fino a che morì sotto i colpi. Essendosi questo misfatto ritenuto, in mezzo a tante calamità, come un prodigio, fu ordinato ai decemviri di consultare i libri, e Quinto Fabio Pittore fu mandato a Delfo a consultare l’oracolo con quali preghiere e suppliche azioni si potessero placare gli dei, e quale sarebbe la fine di tante sciagure. Intanto, secondo le prescrizioni dei Libri fatali, furono compiuti alcuni sacrifici straordinari, tra i quali un uomo e una donna di Gallia, e un greco e una greca furono messi vivi sotterra nel Foro Boario in un recinto di pietre già in precedenza insanguinato da vittime umane, con rito che però non era romano.